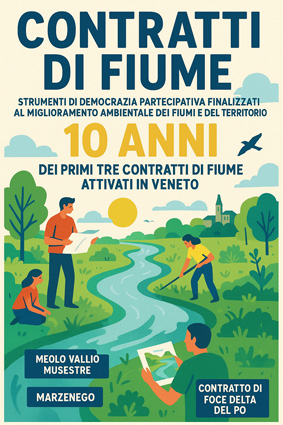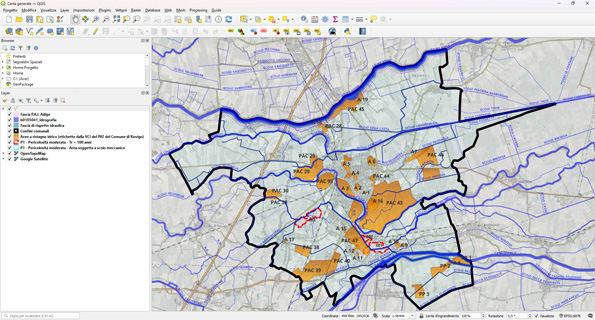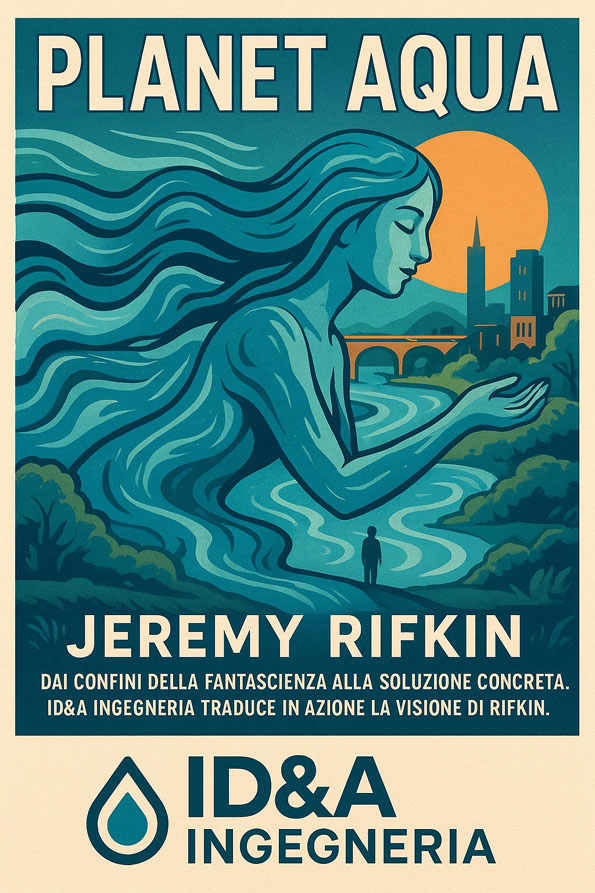…
Sono trascorsi dieci anni.
Un decennio da quando, nel 2014, la Regione del Veneto accese una scintilla di speranza per la gestione delle acque, finanziando l’attivazione di tre ambiziosi processi partecipativi: il Contratto di Fiume Marzenego, il Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre e il Contratto di Foce del Delta del Po.
Oggi, guardando indietro, la domanda sorge spontanea: cosa rimane di quella stagione di grande fermento? La risposta, purtroppo, è desolante: “poco o niente, se non le aspettative tradite”.
I Contratti di Fiume non sono semplici accordi tecnici; sono, per loro natura, processi di governance partecipativa. Il loro obiettivo è nobile e complesso: mettere attorno a un tavolo tutti i portatori di interesse – istituzionali e della società civile – per definire una strategia condivisa finalizzata al miglioramento delle componenti ambientali, sociali ed economiche dei bacini fluviali.
E l’inizio fu davvero promettente.
Ricordiamo l’entusiasmo di quei mesi: i Consorzi di Bonifica, le amministrazioni locali, gli agricoltori, le associazioni ambientaliste, e persino le comunità più attive sul territorio come pescatori e canoisti. Tutti risposero alla chiamata. Si tennero incontri, tavoli tecnici, assemblee pubbliche. Si accumulò un capitale inestimabile di energie, risorse intellettuali, analisi e volontà di collaborazione. L’obiettivo sembrava a portata di mano: sanare ferite ambientali, migliorare la qualità delle acque e la fruibilità dei territori.
Quel fermento fu tale da attirare anche l’attenzione dei media nazionali. Ne è testimonianza un eccellente documentario che Luca Mercalli, nel 2015, dedicò proprio all’esperienza del Contratto di Fiume Meolo Vallio Musestre, trasmesso su RAI 3 nel corso della sua trasmissione “Scala Mercalli”.
Questo video, rivisto oggi, suona come un reperto archeologico di un futuro che non è mai arrivato.
Il meccanismo, infatti, si inceppò sul più bello. Il momento della verità, per i Contratti di Fiume, è la sottoscrizione del Piano di Azione: il documento finale, la dichiarazione concreta con cui tutti i soggetti si impegnano ad attuare azioni specifiche per il bene comune del fiume.
Fu proprio lì che l’intero castello crollò. Al momento di passare dalle parole ai fatti, dalle dichiarazioni d’intenti agli impegni vincolanti, la visione d’insieme si frantumò. Come spesso accaduto nella gestione del territorio veneto (un tema ampiamente dibattuto, anche in saggi come “Il governo delle acque in Veneto”), gli interessi particolari prevalsero sul bene collettivo. “Ogni soggetto andò per conto proprio”, e i processi si arenarono, senza mai giungere a una deliberazione concreta finale.
Oggi, a dieci anni di distanza, celebriamo un vano anniversario. Quei tavoli sono vuoti, l’entusiasmo si è spento e i problemi dei nostri fiumi restano.
La lezione più amara è che ricostruire quel livello di fiducia e mobilitazione richiederà un tempo enorme. Le energie e le risorse intellettuali dissipate in quel fallimento non si ricreano con un nuovo bando regionale. È probabile che dovremo attendere altri quindici anni prima che processi partecipativi di simile portata possano di nuovo catalizzare la stessa volontà di collaborazione.
Il decennale dei Contratti di Fiume in Veneto non è una festa, ma un monito: la partecipazione, senza la volontà politica di portarla a compimento superando i veti incrociati, rimane solo un esercizio di stile.
E i fiumi, intanto, continuano ad aspettare.